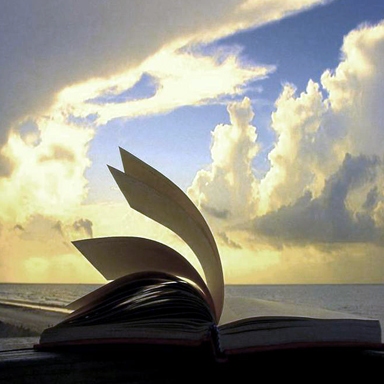15 anni. Metà della
vita. Mica un fardello da niente, riempirli di canzoni.
Voglio dire, quanto può
cambiare una persona in quindici anni? Quanto sono cambiata io, con gli orizzonti
sempre nuovi dentro a un trolley, le passioni che sbiadiscono, gli sbalzi d'umore? Io che andavo al liceo con una cassettina nel
walkman, e mi portavo il lettore cd ad una gita in
inghilterra. Io che ascoltavo l'iPod sul treno per
l'Università. Quattro
tracce per Trieste. Molte di piú per
Parma. Almeno due album su di un volo per
Málaga. Io che, nell'attesa di un corriere Dhl,
ho installato Spotify pure sul cellulare. C'era la stessa voce,
dentro. Sempre lo stesso timbro, a rincorrermi mentre crescevo. E ora
mi sembra assurdo, se ci penso. Perché, in fondo, é una delle mie
poche costanti. Perché c'é stato un suo concerto sullo sfondo di
ogni tappa importante. Il primo. Il mondiale del 2006. I pianti
catartici in teatro. Il rientro dall'Erasmus. C'é stato lui,
puntuale come la più molesta delle sveglie, a ricordarmi il passato anche
mentre lo ricercavo in altri lidi. Vorrei. Vorrei che sparisce dalla
scaletta come Dicono di Me dai pre-concerti spagnoli. Proprio adesso
che ho la sensazione – questa sensazione assurda – che un qualche tipo di cerchio si sia chiuso.
É passata quasi una settimana, dal live di Cesare Cremonini a Conegliano. Eppure, se ci penso, mi sorprendo ancora a sorridere tra me e me. 15 anni. “Ho la sensazione che mi abbiate dato fiducia”, dice ringraziando su quel palco enorme. Ed ogni volta é come se non fossero passati. Tra le transenne mi aspettano le stesse persone, gli stessi abbracci. Hanno il sapore dei ricordi condivisi, l'aspetto di un discorso da riprendere, lasciato in sospeso appena un secondo fa. Non é stato solo un bel concerto: é stata una bella giornata. Coi crampi alla pancia dal troppo ridere. Gli aneddoti sugli spara coriandoli comprati dai cinesi. I camerieri carini, i turni in bagno, la gente che li scambia per una processione finalizzata alle foto. Attese organizzate. Attese calme. File che hanno il sapore dei re-incontri e della gioia, malgrado tutti i lividi e i disagi. “Cosí ha senso”, mi scopro a pensare. “Era per questo che lo facevo”.
Poi le
canzoni. Soprattutto quelle. Il film dell'esistenza che si srotola su
un palco degno delle migliori star internazionali. Occupa da solo
mezzo parterre, tra esplosioni di luci e pianoforti a comparsa. Una
sorta di M rovesciata che lascia proprio a tutti, finalmente, il
miracolo concreto di una bella visuale. Inizia, quel film, dietro ad
una tenda bianca. La sagoma di Cesare in controluce sulle note
dell'intro, e subito rischio, ancora una volta, di lasciarmi andare
ai paragoni. Ma basta ascoltare le prime note di Logico, e ricordo dove sono. Non hanno senso, i paragoni. Perché Cremonini é uno di quegli artisti che si assumono il rischio di iniziare con una hit. La leggo come una sicurezza
ferma, ai limiti di una giustificata presunzione. Come a dire “io
me lo posso permettere”. A intendere che di canzoni buone ne ha
abbastanza da non temere l'inizio col botto. Non calerá, il ritmo.
Non si smorzerá l'entusiasmo. Vedrete.
E
infatti. Si alternano come una collana di suoni psichedelici: Dicono
di Me e il viaggio in autobus a Nerja; Stupido a chi e l'Arena di
Verona; Vieni a Vedere perché e Dani Martín. Si palesano La vespa e
i sedici anni in discoteca. Vent'anni per sempre, Il Comico,
PadreMadre e un festival della Vodafone a Lignano, Latin Lover e
l'incontro di Cesena, i brividi dell'immedesimazione filo-ispanica su Fare e Disfare. E
ancora “I Love You” con lo strascico di un'intera estate, La
nuova stella di Broadway che piace a mio padre. C'é spazio persino per “Il
primo bacio sulla Luna”, che per me ha i tornanti e le distese
verdi della strada per Ronda. Che mi spiazza, disorienta, e
inevitabilmente mi commuove.
La miglior scaletta che abbia mai assemblato tra tutti i suoi tour, questo mi sembra. Perché non riesco a smettere nemmeno un solo istante di cantare a squarciagola. E mi si increspano i capelli per le gocce di sudore, tra i salti e riflettori che mi illuminano il viso. Mentre impreco in direzione del cameraman che mi incolla al maxischermo e mi condanna ai “ti ho vistaa”, mentre ad ogni nuovo accordo mi sfugge dalle labbra che “questa l'adoro”. Un repertorio ad alta densità di successi, che predilige i ritmi sostenuti e sa stupire anche in quelli piú distesi. Perché Io e Anna si accompagna a un video in bianco e nero dalla fotografia impeccabile, e racconta una storia piú di quanto il testo faccia giá. Perché al piano, questa volta, non ci sono Vorrei o Niente di Piú ma Una Come Te e Figlio di Un Re. Collocate dove non ti aspetti, colorate di una tinta nuova. Ecco, forse proprio “Figlio di un Re” é il brano che mi convince meno, perché ne amavo – soprattutto – le sonoritá corali che la versione intimista mi pare un po' appiattisca.
Peró
fa niente, perché poi c'é Marmellata 25. C'é Cesare che si china a
cantarmi negli occhi che “mi hai lasciato pure tu”, e io che rido
pensando che, invece, la sua musica é una delle poche cose che non ho lasciato
mai. C'é GreyGoose, ancora. C'é Mondo. C'é Un Giorno Migliore.
Che, come tutte le tradizioni che si rispettino, é ormai da anni
destinata a sigillare di speranza lo show.
Uno
show che ha trasformato due ore in pochi minuti. 24 canzoni in una
proiezione di polaroid di esperienze fatte. Una notte in hotel
nell'insonnia dell'adrenalina.